Che ci stiano facendo fuori il sistema pubblico di scuola e università dovrebbe ormai essere abbastanza chiaro. E se per qualcuno non lo è, sarà il caso che si informi. Non so, onestamente se ci saranno più le condizioni minime per lavorare in maniera decorosa. Le proteste delle scuole e delle università sono state “silenziate” nell’indifferenza di un’estate afosa, in cui le vacanze sembrano non arrivare mai.
Non è vacanza per i genitori e docenti impegnati nella Difesa della Scuola della Costituzione.
Non è vacanza per i precari di ogni ordine e grado.
Non è vacanza per chi protesta nelle università.
E l’amarezza ti lascia in bocca un sapore metallico e torni indietro con il pensiero all’entusiasmo degli inizi (parlo del 1997 e sembra una vita!) in cui eravamo convinte che la scuola primaria fosse l’avamposto di un cambiamento che avrebbe gradualmente coinvolto tutti gli altri gradi di scuola sotto il segno del lavoro di team, della condivisione delle conoscenze, degli spazi interdisciplinari, della ricerca continua… Esemplare l’iniziativa dell’autoriforma gentile, in cui ci si permetteva addirittura di disquisire sull’esistenza
nella scuola italiana [di] una gerarchia maschilista che fa sì che man mano che si sale negli ordini di scuola si debba emancipare l’insegnamento dai legami affettivi attraverso cui passa l’apprendimento nell’infanzia, atteggiamento tipicamente femminile incarnato dalla “maestra”, per passare al sapere neutro condensato nella figura del “professore”, considerato più nobile perché più vicino al Sapere accademico…
Anche la ricerca in didattica da qualche anno sottolinea con enfasi il legame tra affettività e apprendimento, ma questo non sortisce effetti: la legislazione scolastica e il ministero dimostrano di non recepire nulla, perché per farlo dovrebbero capovolgere i criteri del valore e le sue gerarchie. A riprova di questa mentalità troppo spesso dominante, nell’ultima stesura della riforma i riferimenti al senso relazionale dell’insegnamento sono limitati ai gradini più “bassi” dell’istruzione; nei gradi “alti” la scuola sembra dover soccombere alla certificazione minuta delle competenze e al tecnicismo esasperato perché lì si giocherebbe il valore supremo del sapere.
Nella realtà molti/e docenti delle scuole superiori testimoniano che, soprattutto con queste ultime generazioni di ragazzi e ragazze, questo modo di porsi produce frustrazione e perdita di senso sia tra chi insegna che tra chi apprende e un preoccupante fallimento nell’apprendimento.
Certo, non tutte ci credevano o erano contente di questo cambiamento ma si confidava nel ricambio generazionale. Come è andata è sotto gli occhi di tutti: la nuova generazione di maestre è cresciuta all’ombra della Moratti e noi siamo rimaste in mezzo. Sono tornati la “mia” classe, i “miei” voti, le “mie” ore e via dicendo. Mio, mio, mio, mio così nessuno può “sindacare” sui fatti “tuoi”. E le maestre sono state ricacciate dietro ai quaderni a righe e a quadretti, le cantilene a memoria, la solitudine di una “cattedra minore”. Tutti gli approfondimenti, le nuove competenze, gli aggiornamenti pagati di tasca propria gettati nel cestino per soddisfare il frustrato di turno chiamato alla corte del MIUR a ridisegnare la scuola “che è stata” e sancire la superiorità di chi ha diritto a chiamarsi prof e chi no. Ma io preferisco l’appellativo di maestra. Non mi offende.
Allora – per arrivare al punto che ha sollecitato questo post – le mie remore rispetto al Manifesto degli insegnanti non nascono dal fatto che il testo non faccia vibrare le corde della mia sensibilità – come commenta Antonio Saccoccio sul blog di Carlo Columba – ma che ci si debba/possa riconoscere o meno in quell’insegnante “eroico”, uomo nuovo che si scorge dietro il manifesto, sic et simpliciter, prendere o lasciare.
E’ necessario più dell’aria un nuovo senso di appartenenza (ne parla anche Massa nell’ultimo capitolo di Cambiare la scuola), forse inedito da un certo punto di vista, che però deve derivare – oltre che dalla condivisione di un fondamentale ed ineludibile rispetto per l’altro e per le sue specificità – anche dal lavorare fianco a fianco con i colleghi, dall’imparare da loro, dall’insegnare loro…
Cose significative da imparare e realizzare. Tempi adeguati di decantazione e rielaborazione… Possibilità di acquisire abilità ed esercitare competenze, piuttosto che emissione di verdetti sulla loro acquisizione. Forme e stili di vita al posto di nozioni e valori. Esplorazioni e sperimentazioni, prove individuali e di gruppo, rituali sensati di iniziazione sociale, performance concrete di cui si possa verificare una spendibilità immediata, invece di compiti a casa o turni di interrogazioni…
Il Maestro del manifesto sembra solo (l’utilizzo del maschile è voluto). Se lascia la cattedra, lo fa ad una sua creatura. Nobile ma non basta nell’era dell’intelligenza connettiva/collettiva/multipla (come preferite). Dov’è la comunità dei docenti?
La scuola la si cambia in primo luogo imparando a lavorare insieme, concependo come naturale anche insegnare e apprendere da chi fa il tuo stesso mestiere. Con la naturalezza e l’entusiasmo di chi ama apprendere. Perché – come scrivevo in un’altra “risposta” al mio amico Andreas
Fenomenologicamente (e qui vado a braccio sulle letture di Vanna Iori), se si accetta il processo di insegnamento/apprendimento come un processo vitale, di interazione tra esistenze, si riconosce anche lo studente come soggetto primo dell’azione didattica.
E’ il suo bisogno di apprendere a determinare il processo. Se si può concepire un bisogno di apprendere senza qualcuno in grado di soddisfarlo, non si può fare altrettanto circa il “bisogno” di insegnare…
Il docente esiste perché e quando qualcuno lo riconosce come tale. E non credo ci sia molto altro da aggiungere.


 Iscrizioni via Email...
Iscrizioni via Email...

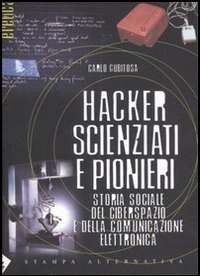






iamarf
16 luglio 2010
Gli insegnanti sono esseri umani, che sono vivi, e quindi non si possono cambiare e nemmeno orientare apprezzabilmente, per fortuna. Gli esseri viventi abitano un contesto e ad esso reagiscono e si adattano.
Il dispositivo in realtà è un sistema complesso e vivo, e quindi non si può cambiare e nemmeno orientare. Anzi, ancora meno perché è più grande e quindi quindi ha maggiore inerzia.
La sua inerzia è inoltre accresciuta dalla sua circolarità. Per cambiare il sistema bisogna vedere il problema ma il sistema non produce membri in grado di vedere il problema e quindi è molto difficile che cambi.
Questo è il motivo principale per cui le innovazioni vengono sempre fuori dai sistemi perché questi ultimi tendono ad automantenersi.
Non vale quindi operare sulle parti del sistema come se questo fosse una macchina da riparare, perché non è una macchina bensì una cosa viva.
Questo equivoco deriva dal retaggio di una cultura allo stadio ancora infantile, cultura che impedisce agli uomini istruiti di vedere il problema, ivi inclusi la quasi totalità degli amministratori e dei politici.
Questa è una visione che corrisponde a entrare in un’ameba con una chiave inglese per vedere di cambiarne il comportamento: ho non succede niente o l’ameba cambia in modo imprevedebile e quasi certamente perisce.
Inutile quindi agire sulle categorie classiche che non sono altro che parti del sistema.
Le cose vive, cambiano solo se perturbate dall’esterno, in questo un qualsiasi sistema composto di umani non differisce da un’ameba.
E’ quindi necessario farsi venire in mente modi per uscire dal circolo che sostiene il sistema.
Prima era praticamente impossibile, raro e del tutto fortuito. Oggi la rete ha cambiato completamente questa prospettiva.
Si tratta di rimanere con una gamba nel sistema piantando però l’altra saldamente fuori in maniera da non perderlo di vista ma, allo stesso tempo, per essere in grado di creare alternative e stimoli esterni, cercando di non lasciare niente di inesplorato.
Oppure di uscire dal sistema e tentare di operare fuori e basta, la soluzione ovvia per chi ne è già fuori.
Ma per chi è dentro si pone il problema e io mi ci arrovello da qualche anno. In questo momento penso che convenga rimanere a cavallo mantenendo la “posizione” ma lasciando la testa libera di agire fuori.
Non è questione di eroi. E’ questione di impiegare la rete per raccogliere le idee e la spinta di coloro che hanno la possibilità e la capacità di “tenere la testa fuori”, far sì che facciano rete in modo da moltiplicare le loro idee e le loro spinte.
Non è questione di eroi, non è questione di combattere non è questione di abbattere, non è questione di utilizzare tutti gli attrezzi tipicamente maschili-militari: questo è passato. Le avanguardie passate, benemerite, marxiste, futuriste ecc. devono insegnare anche questo. Solo un demente può perpetuare visioni statiche in un mondo dinamico.
Le attuali categorie che si vestono dei colori di quelle avanguardie e non dichiarano e praticano i modi nuovi di resurrezione, sono, salvo eccezioni, bande di opportunisti, faccendieri, mariuoli di vario rango, e furfanti veri e propri. I media non altro che questo da documentare, dalle nostre parti.
E’ questione di potenziare la sensibilità per le creature vive, dai microorganismi ai sistemi macroeconomici, passando per l’uomo. E’ questione di fare appello alla capacità di osservazione, alla capacità di cura, alla capacità di stabilire relazioni e di coltivarle.
Queste sono prerogative della donna. Per riuscire a realizzare lo spostamento di paradigma, dallo spezzare l’oggetto per conoscerlo all’osservarne le relazioni interne e le relazioni con l’esterno, occorrono le qualità della donna. Il futuro è nella donna ma bisogna che questa si affretti a deporre le armi maschili che sta imparando ad usare un po’ troppo bene. I mezzi propri della donna non comprendono armi. I mezzi della donna non contemplano calcoli. La donna agisce perché vede l’imperativo e il valore assoluto della vita, se non si è fatta corrompere. Non misura i corrispettivi.
Leggete quel manifesto con la mente e l’anima della donna e non vi vedrete niente di eroico ma giusto quello che la donna ha sempre offerto al mondo e che è un’offerta immensa che l’uomo s’è sempre guardato bene dal calcolare. E’ vero che è incalcolabile ma non ci ha provato nemmeno.
Il futuro può essere pensato oramai solo dalla donna.
"Mi piace""Mi piace"
Maria Grazia
16 luglio 2010
Il dispositivo di cui io parlo è un dispositivo pedagogico e tu dovresti saperlo bene. Prendo atto della tua visione, anche se non ce n’era bisogno. Magari ne riparliamo a quattr’occhi 😉
"Mi piace""Mi piace"
iamarf
16 luglio 2010
ho tempo ora di ritornare con più precisione sulla fine del post, prima non facevo in tempo
ma in quel manifesto lo si urla addirittura che lo studente è il soggetto primo
laddove l’insegnante lo aiuta semplicemente a sviluppare l’innata propensione alla meraviglia
dichiarando di non avere verità rivelate da dare
dichiarando di lavorare egli stesso sui suoi errori
io credo che una persona che veramente abbia questo rispetto, questa visione della verità e dell’errore non potrà che collaborare sia con gli studenti che con gli altri insegnanti, mi sembra un corollario ovvio
poi, certo, si può specificare meglio tutto
ma io sono sicuro che su quei tre punti crescerebbe un mondo completamente diverso, la cura per le comunità verrebbe spontaneamente invece quei tre punti li ho sempre visti calpestati, eccezioni a parte.
"Mi piace""Mi piace"
iamarf
16 luglio 2010
certamente, a quattr’occhi 🙂
"Mi piace""Mi piace"
Maria Grazia
16 luglio 2010
Io sento profondamente miei i principi da te sintetizzati e non voglio fare il bastian contrario, anche se poi finisco sempre a fare quello… 🙂 Noi non siamo uguali come docenti eppure ci piace il lavoro dell’altro ed abbiamo imparato tanto reciprocamente. Il desiderio di apprendere, l’amore per l’apprendimento si manifesta non solo aprendosi alla relazione bidirezionale con lo studente (del resto non ci può essere insegnamento senza un contestuale apprendimento, pur inconsapevole e latente) ma anche continuando a ricercare tra i nostri “pari” confronto e nuovi punti di vista.
La Rete ci aiuta in questo mettendoci in contatto con chi ha questo stesso desiderio ma è lontano fisicamente da noi. E quelli che sono vicini? Che lavorano nell’aula accanto? Che hanno a che fare con i nostri stessi ragazzi?
E’ importante coinvolgerli perché uno solo potrà incidere sulla vita dei singoli ma non sulla modifica dell’intero sistema. Nel mio immaginario, però, preferisco il coinvolgimento per “immersione”, sporcandosi le mani insieme, insomma. E’ una questione di stile. Non di valori. 🙂
Comunque continuo a seguire l’evoluzione dell’iniziativa… 😉
"Mi piace""Mi piace"
iamarf
16 luglio 2010
🙂
"Mi piace""Mi piace"